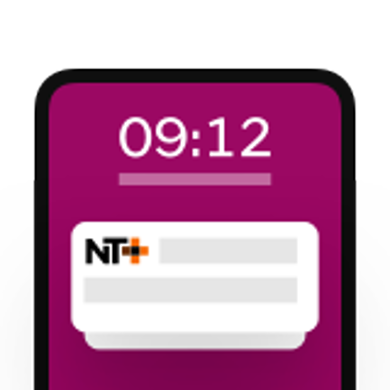Università, in tre anni destinato alla pensione il 20% degli ordinari
Tra quest’anno e i prossimi due un professore ordinario ogni cinque lascerà la cattedra; nell’area degli studi classici l’abbandono riguarda quasi un ordinario su tre, a medicina, storia e scienze politiche esce di scena un cattedratico ogni quattro, mentre l’esodo è un po’ meno intenso a matematica, economia e giurisprudenza. Allargando lo sguardo ai professori di seconda fascia e ai ricercatori, dove le pensioni sono meno frequenti perché l’età media è ovviamente più bassa, la via verso l’uscita rimane comunque affollata: poco meno del 10% dei docenti attuali ha ancora al massimo due anni accademici da passare in aula.
I numeri messi in fila dai censimenti ministeriali parlano di un esodo in pieno corso, destinato ad aprire spazi enormi negli organici. Il tutto accade mentre, dopo anni di dieta forzata, il turn over tornerà al 100% dall’anno prossimo, quando il sistema universitario potrà dedicare a promozioni e nuove assunzioni tutti i risparmi prodotti dalle uscite. Un’occasione importante per ridisegnare l’architettura accademica: verrà sfruttata?
Il turn over
Proprio l’evocazione del «turn over», punta dell’iceberg burocratico che tra punti organico, indicatori di spesa e decreti vari domina la gestione del personale accademico, alimenta qualche dubbio legittimo. A decidere il «reclutamento», altro termine del lessico normativo che fa pensare più all’esercito che alle scienze, è stata finora la dialettica complicata fra due fattori: gli interessi dei diversi gruppi accademici, alla base fra l’altro delle alleanze che portano all’elezione dei rettori, e una griglia di leggi e regole sempre più di dettaglio, spesso nate sull’onda delle varie “concorsopoli”, che hanno finito per far ingaggiare battaglie più sulla forma che sulla sostanza delle scelte.
L’austherity anticrisi
In queste dinamiche la legge della domanda e dell’offerta non vale per la ragione semplice che la domanda, rappresentata dagli studenti, non sembra aver avuto alcun peso. Per accorgersene basta un indicatore banale, che mette a confronto l’evoluzione vissuta negli ultimi dieci anni dalla geografia universitaria in termini di docenti e studenti. La lunga fase dell’austherity anti-crisi ha ridotto del 16% i docenti mentre gli iscritti agli atenei sono aumentati dell’8,6%, anche grazie alla ripresina degli ultimi due anni. Ma è nelle singole aree di studio che si incontrano le contraddizioni più evidenti. Quella che le etichette ministeriali definiscono «area sociale», e che in pratica comprende economia, giurisprudenza e scienze politiche, è l’unica a non guadagnare iscritti rispetto a dieci anni fa, ma è anche quella che subisce l’emorragia più contenuta di docenti (-4,6%): la forbice fra la robustezza del corpo docente e la platea degli studenti si allarga invece nell’area medica, che paga anche un certo gigantismo del passato, e in quella scientifica, che si è alleggerita di un docente su sei mentre gli studenti sono aumentati del 18,6 per cento. E nello stesso periodo gli atenei del Centro-Nord, che hanno visto crescere dell’11,6% i propri iscritti, hanno subito in media la stessa perdita di professori che si è registrata al Sud, dove gli studenti sono calati del 2 per cento.
Certo, il rapporto studenti/docenti è solo uno dei parametri da prendere in considerazione, all’interno di una strategia che dovrebbe scegliere anche un pacchetto di discipline innovative su cui puntare anche per creare una nuova domanda di competenze. Tutte scelte, queste, che non possono però farsi strada finché turn over e punti organico continueranno a essere i padroni delle assunzioni, trattando le università come un ufficio dell’anagrafe.

Riposo compensativo alternativo alla paga doppia nel festivo infrasettimanale lavorato
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Permessi studio anche per le università telematiche, ma solo per gli esami
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala